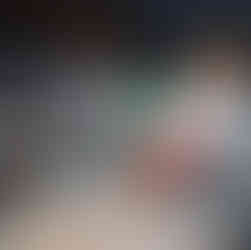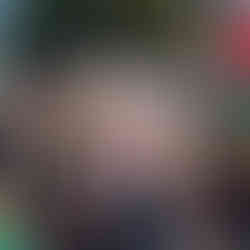La Palestina ci ha guardati negli occhi
- Naomi Kelechi Di Meo
- Oct 14, 2025
- 7 min read

Il 3 ottobre l’Italia si è fermata. Non completamente, ma abbastanza da far rumore. Treni sospesi, porti rallentati, università e scuole con le aule semivuote. Uno sciopero generale che non nasceva da una vertenza economica ma da una vertenza morale. Dalla constatazione che il silenzio istituzionale sulla Palestina non è più sostenibile, che la distanza tra chi governa e chi vive è diventata abisso. Le istituzioni, davanti all’abbordaggio della flottilla umanitaria diretta a Gaza, non hanno mosso un dito. Hanno lasciato che la notizia scorresse come un evento di cronaca, come se non ci riguardasse. Ma ci riguarda. Ogni cittadino di un Paese che vende armi, che intrattiene rapporti con uno stato genocidiario, un etnostato che da decenni pratica pulizia etnica e apartheid, è parte di quel silenzio. E quel silenzio pesa. In tanti, quel venerdì, hanno scelto di interromperlo. Non con comunicati o petizioni, ma con l’unico linguaggio che lo Stato comprende davvero: l’astensione dal lavoro, la sospensione del consenso. La piazza è diventata il contrario dell’istituzione: luogo dove le parole non vengono filtrate, dove le contraddizioni respirano. A Roma, il giorno dopo, il 4 ottobre, l’aria era spessa. Lunga, lenta, densa di corpi, di cartelli, di rabbia, di dolore. Non c’era una folla “pro-palestinese” in senso rituale: c’erano generazioni intere che riconoscevano in quella causa la propria immagine riflessa. Perché la Palestina è il confine di tutto ciò che l’Occidente finge di non vedere di sé: il colonialismo che non muore, la paura di perdere il controllo, la violenza amministrata come ordine.
La flottilla non è la storia, è il mezzo. Il mezzo con cui la storia si rimette in moto. Donne, uomini, parlamentari, giornalisti, medici hanno sfidato l’assedio partendo dal mare, portando aiuti e parole, sapendo che sarebbero stati fermati. È questo il punto: non l’eroismo, ma la scelta di rompere la finzione di impotenza. La loro nave non rappresentava la Palestina, ma il tentativo di infrangere la narrazione dominante secondo cui “non si può fare nulla”. Le istituzioni hanno reagito come sempre: burocraticamente. Hanno discusso di permessi, di regole, di confini. Nessuno ha nominato il senso politico di ciò che stava accadendo: che un potere genocidiario stava difendendo, con le armi, il diritto di imprigionare un popolo intero, e che noi, con la nostra neutralità, ne eravamo garanti.
Quando i corpi scendono in piazza, il potere risponde con il conteggio: quanti erano? Centomila? Duecentomila? Ma ciò che è accaduto il 3 e 4 ottobre non può essere misurato. Perché non è stato solo un atto di solidarietà, ma un atto di rottura interna. L’Italia, scendendo in strada per Gaza, ha guardato sé stessa. Ha riconosciuto il proprio colonialismo mai elaborato, il proprio razzismo quotidiano, l’ipocrisia di un governo che invoca la “difesa dei valori occidentali” mentre finanzia la distruzione sistematica di un popolo. Molti sono scesi in piazza per dire “Palestina libera”, ma nel farlo hanno detto anche “noi liberi”. Liberi da un torpore, da un senso di impotenza costruito. È qui che la Palestina ci ha liberato. Non solo perché ci ha ricordato cosa significa resistere, ma perché ci ha messo di fronte alla verità su di noi: che viviamo in un Paese governato da chi non riconosce l’umanità, né altrove né qui. Il silenzio e la complicità del governo verso Israele ci hanno mostrato quanto poco questo governo rappresenti chi crede nella giustizia, quanto poco sia disposto a prendersi cura degli esseri umani, dei diritti, delle urgenze sociali che attraversano le nostre vite. Se puoi negare un genocidio – l’apice della disumanità – allora tutto il resto diventa irrilevante: la precarietà, la povertà, la cittadinanza negata, le disuguaglianze quotidiane. Riconoscere la disumanità verso la Palestina ha significato riconoscere la nostra stessa disumanizzazione, la misura in cui siamo diventati invisibili agli occhi di chi ci governa.
Questo è il paradosso che illumina questi giorni: credendo di manifestare per la liberazione di altri, abbiamo scoperto che anche noi eravamo prigionieri. Di un linguaggio anestetizzato, di una politica ridotta a spettacolo, di un giornalismo che confonde equilibrio con vigliaccheria. La piazza non ha liberato Gaza, non ancora, ma ha liberato la possibilità stessa di immaginare la libertà. Ha restituito alla parola “giustizia” un significato fisico: camminare insieme, sudare insieme, gridare insieme. Non c’è niente di retorico in questo. È la materia della democrazia, quella che le istituzioni hanno disimparato a toccare.
Il governo Meloni non è solo spettatore di questo scarto, ne è la causa. La sua postura è quella dell’impero travestito da provincia: servile verso chi comanda, feroce verso chi dissente. In questi mesi, ogni voce critica viene trattata come un’intrusione, ogni protesta come un disordine. Ma lo Stato che considera “disturbo” la solidarietà è già in crisi. Le piazze di ottobre non chiedevano consenso, ma riconoscimento: il diritto di non essere complici. E questo diritto non è negoziabile. Si può vietare uno sciopero, si possono disperdere manifestanti, ma non si può annullare la coscienza che nasce da un atto collettivo.
Le istituzioni europee hanno seguito la stessa logica: risoluzioni tiepide, appelli bilanciati, condanne simmetriche. Una retorica di equilibrio che pesa quanto una condanna a morte. Parlano di “pace” ma intendono immobilità, parlano di “dialogo” ma intendono dominazione. L’Europa è diventata ciò che Gaza rappresenta simbolicamente: un recinto sorvegliato da droni, dove si teme l’eccesso di umanità. La differenza è che qui il filo spinato è mentale, e molti hanno deciso di smettere di accarezzarlo.
Questi giorni hanno insegnato che la solidarietà non è un sentimento ma un’azione. Non è l’adesione a un simbolo ma la rottura di un meccanismo. Quando un porto chiude per protesta, quando un treno non parte, quando un professore sospende le lezioni per parlare di Palestina, l’idea di potere vacilla. Il potere si fonda sull’obbedienza, e l’obbedienza, come ogni costruzione umana, può essere interrotta. Il 3 e 4 ottobre sono stati una sospensione collettiva del consenso. Non un episodio ma un varco: la dimostrazione che il blocco può incrinarsi se abbastanza persone decidono di non esserne parte.
Greta Thunberg, accolta insieme agli altri membri della flottilla come un’eroina, ha rifiutato il titolo: «Non sono un’eroe, sto facendo il minimo».In questa risposta c’è la chiave di tutto. L’eroismo è la narrazione con cui il potere neutralizza la disobbedienza: se solo pochi sono capaci di agire, allora la massa può continuare a obbedire. Ma il coraggio non è una risorsa scarsa, è una pratica collettiva. È stato il capitalismo a convincerci del contrario, a isolarci, a renderci precari anche nelle nostre idee. Eppure basta prendersi per mano con qualcun altro per ricordarsi che non si è soli, che la lotta — quando è condivisa — smette di essere un sacrificio e diventa una possibilità. L’eroismo mediatico è la forma più sottile della deresponsabilizzazione collettiva: se solo gli eroi agiscono, allora noi possiamo continuare a non farlo. Invece il coraggio è una facoltà comune, che il capitalismo e il potere ci hanno insegnato a rimuovere. Ci hanno resi soli, precari anche nel credere alle nostre idee, convinti che la lotta sia un affare individuale e non una possibilità condivisa. Ma quando ti prendi per mano con qualcuno, quando riconosci nell’altro la tua stessa necessità, il coraggio si moltiplica. Non tutti possono salire su una flottilla, ma ognuno può scegliere come esporsi: chi può andare in piazza, chi può fermarsi dal lavoro, chi può scegliere cosa comprare, cosa non finanziare, quali prodotti non acquistare per non alimentare la macchina che sostiene la guerra. È questo il punto: il coraggio non è una dote, è un legame. E quando diventa collettivo, smette di essere un gesto straordinario e diventa semplicemente umano.
Molti hanno criticato la piazza: troppo radicale, troppo disordinata, troppo carica. Ma la piazza, in quei giorni, era più ordinata di qualsiasi governo. Era fatta di corpi che hanno scelto la vita contro l’indifferenza. E non importa se qualcuno prova a ridurla a cronaca di scontri o a folklore di sinistra: chi c’era sa che era qualcosa di più. Era la prova che il senso di giustizia non si può delegare. Che la liberazione della Palestina non è un tema “estero”, ma una cartina di tornasole del mondo che stiamo accettando.
In ogni volto c’era la consapevolezza che non si può restare neutrali davanti a un genocidio. Eppure, la parola “genocidio” è ancora censurata nei comunicati ufficiali, nei telegiornali, nelle aule parlamentari. Non perché sia sbagliata, ma perché costringerebbe a riconoscere la complicità di chi parla. È più comodo dire “conflitto”, come se fosse una disputa simmetrica. Ma le parole non sono neutre: quando scegli di non nominare la violenza, ne diventi parte.
Chi è sceso in piazza non cercava purezza, cercava verità. Una verità scomoda, perché ci riguarda tutti. La Palestina è il punto di convergenza tra colonialismo, capitalismo e razzismo. È la dimostrazione vivente che la libertà di alcuni si costruisce sulla prigionia di altri. Ed è per questo che la sua liberazione è anche la nostra. Lo hanno capito i portuali che si rifiutano di caricare armi, gli studenti che occupano le università, le madri che tengono i figli per mano sotto una bandiera rossa, verde, nera e bianca.
Non serve essere palestinesi per capire Gaza, basta essere umani e ancora capaci di vergogna. Ma serve anche qualcosa di più raro: la volontà di agire. Non basta indignarsi, bisogna interrompere la complicità. Le piazze di ottobre hanno fatto questo: hanno interrotto. Hanno detto no, e quel no è stato il gesto politico più radicale di questo tempo.
Chi si aspettava un segnale dalle istituzioni ha capito che non arriverà. Che la giustizia, come sempre, nasce dal basso. Che la storia non la scrivono i governi, ma i corpi che decidono di farsi presenza. La flottilla, la piazza, lo sciopero: non sono simboli da archiviare, ma mezzi di liberazione, atti di disobbedienza che spostano il centro di gravità del potere.
Alla fine, la domanda non è più “cosa possiamo fare per la Palestina”, ma “cosa siamo disposti a smettere di fare per il sistema che la opprime”. È una domanda che riguarda la nostra vita quotidiana: il lavoro, i consumi, i voti, il silenzio. È lì che si gioca la vera politica.
Il 3 e 4 ottobre non sono stati solo due giorni di protesta, ma un inizio. Un passaggio da spettatori a testimoni. Secondo le stime dei movimenti, più di due milioni di persone hanno attraversato le piazze italiane: studenti, lavoratori, famiglie, intere classi. Due milioni di voci che hanno detto che non vogliono più essere complici, né sudditi. La storia non si è ancora mossa, ma qualcosa in noi sì. Abbiamo capito che la liberazione non è un evento, ma un processo. Che non è un favore che si concede, ma una responsabilità che si prende. Che il mare che separa non è poi così vasto, se cominciamo a nuotare nella stessa direzione.